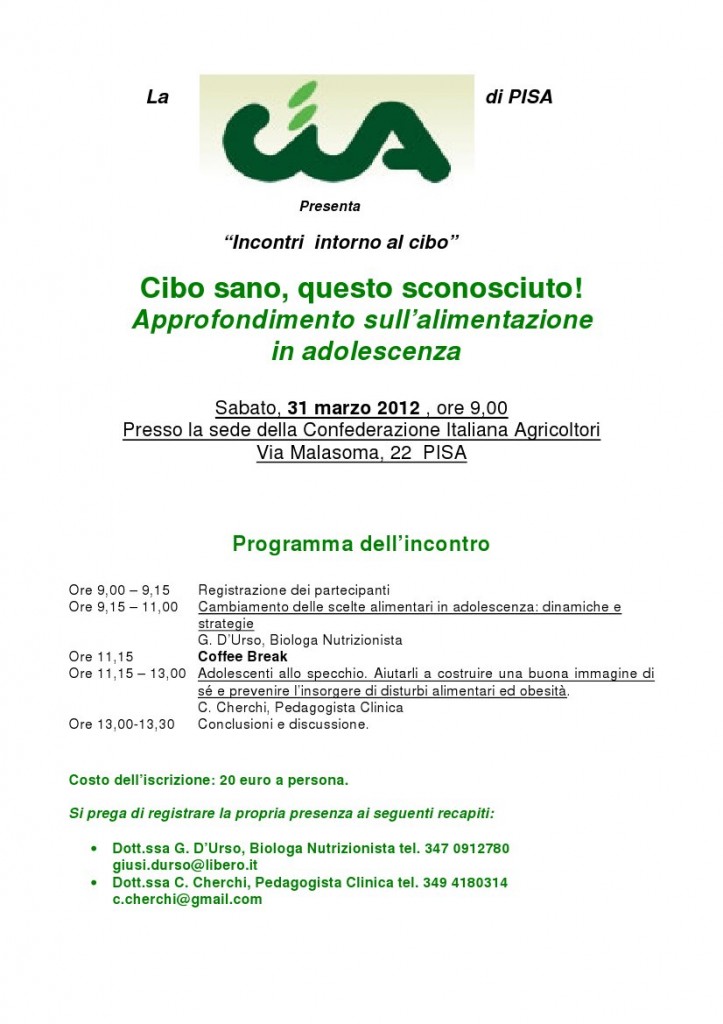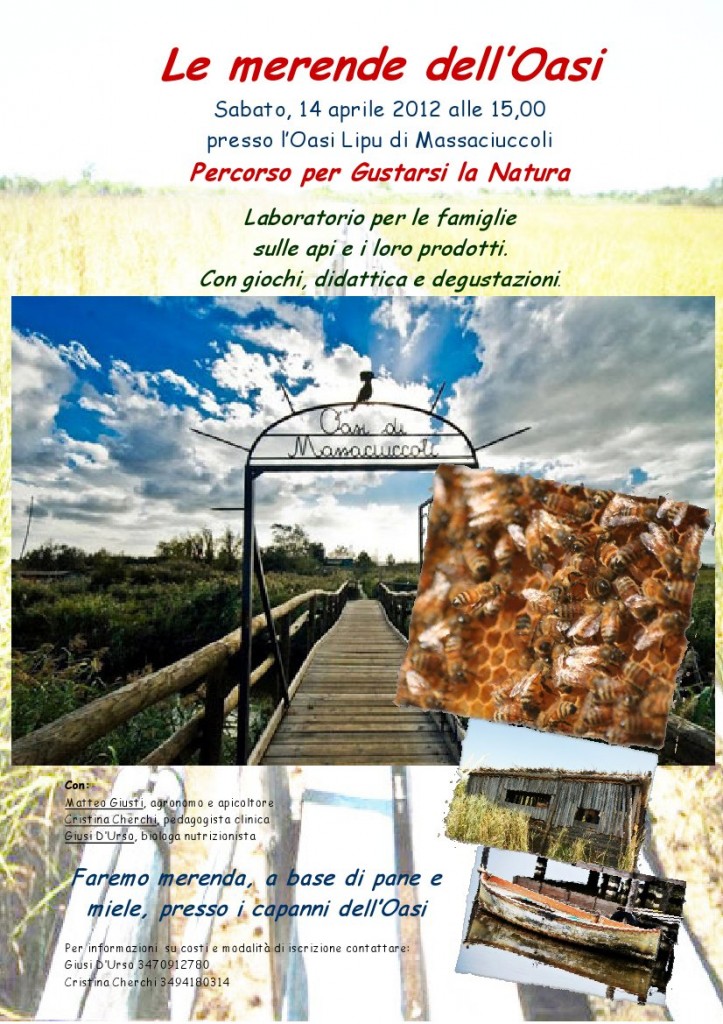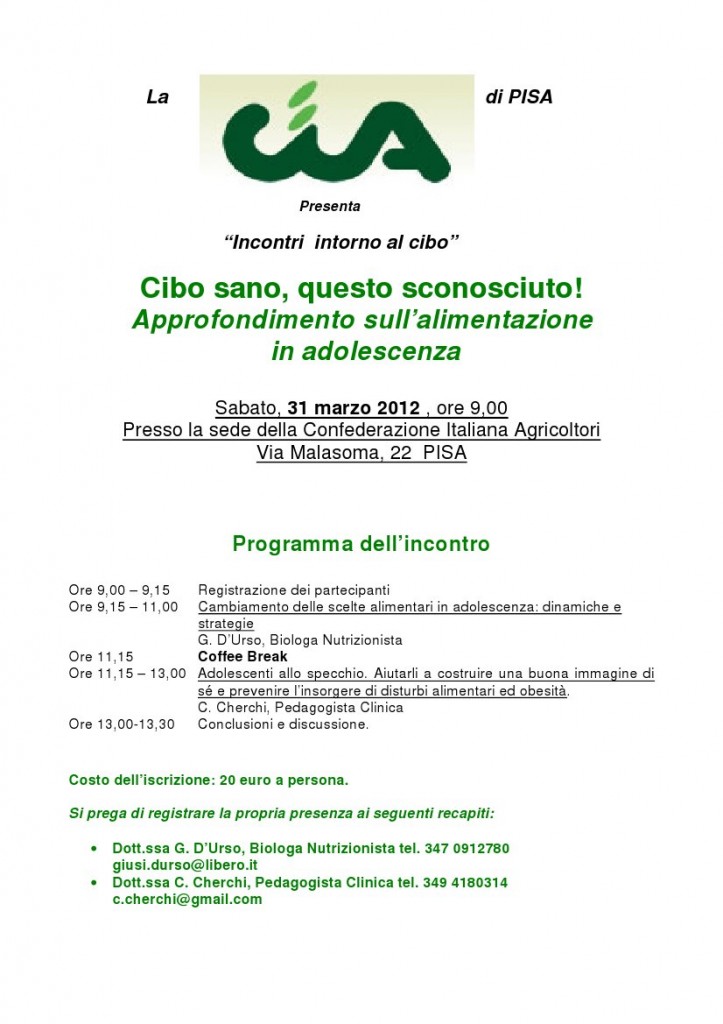Qualche anno fa il mondo scientifico rivolse una grande attenzione e un’enorme mole di studi alle funzioni intestinali, soprattutto quelle svolte dalla parete assorbente del tenue, e, scoprendone l’importanza e l’influenza su altri sistemi ed apparati, soprannominò l’intestino il “secondo cervello”.
Negli ultimi anni assistiamo ad un’analoga attenzione rivolta, questa volta, al tessuto adiposo (il grasso), le cui funzioni, in realtà, pare vadano molto al di là del mero accumulo di acidi grassi come fonte energetica.
La fisiologia del tessuto adiposo bianco, infatti, si sta rivelando interessante e complessa, tanto da renderlo degno dell’appellativo di “organo endocrino”. La storia “endocrinologica” dell’adipe fa capo soprattutto alla scoperta della leptina, avvenuta nel 1994. Si tratta di una sostanza che, agendo attraverso il sistema simpatico, inibisce la spesa energetica. I livelli circolanti di leptina, importante anche nei fenomeni riproduttivi e nella plasticità neuronale, sono strettamente collegati alla massa grassa e la sua secrezione è aumentata nell’obesità.
Fra le tante molecole prodotte dal tessuto adiposo, l’adiponectina ha la funzione di amplificare la sensibilità all’insulina. La sua secrezione è ridotta nell’obesità.
Questi due ormoni, dunque, svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione del metabolismo energetico e nel mantenimento del peso corporeo.
Riguardo al contenuto di grassi accumulati nelle cellule adipose (adipociti), dagli studi è emerso che un eccesso lipidico può attivare una serie di segnali chimici tipici dell’infiammazione. L’ipotesi suggestiva dell’infiammazione, e della conseguente progressiva morte cellulare degli adipociti, come meccanismo tessutale tipico dell’obesità, sembra ormai più che probabile: la produzione di sostanze infiammatorie e la necrosi delle cellule adipose sono infatti circa tre volte superiori nei soggetti obesi, rispetto a quelle dei normopeso.
Ma non basta: gli adipociti producono sostanze che agiscono localmente, inibendo l’infiammazione, mantenendo la forma delle cellule stesse, regolandone lo sviluppo e le comunicazioni con altri organi.
Al momento, dunque, quello che sappiamo sul grasso è che, oltre ad essere, quando in eccesso, un fattore di rischio per importanti malattie, esso è anche un organo “regolatore”; una sorta di centralina chimica che ci mette in relazione con il mondo esterno, in particolare con il cibo, attraverso la regolazione di sensazioni quali l’appetito, la spinta alla ricerca di alimenti e la sazietà; un vero e proprio organo di “interfaccia” che reagisce a stimoli negativi producendo una batteria di sostanze chimiche che lo invadono e che segnalano una disfunzione agli altri organi (immunitario, endocrino, gastro-enterico).
Chi mai avrebbe immaginato, fino a pochi anni fa, guardandosi allo specchio e magari lamentandosi un po’ per quegli antiestetici cuscinetti adiposi, che fossero la sede di un tale complesso fermento?!
Chissà che questo non renda il grasso un po’ più simpatico, almeno agli occhi di noi donne, sempre alla ricerca della linea perfetta!
Per approfondire:
Infiammatory mediators: tracing links between obesity and osteoarthritis
Role of adipokine and other infiammatory mediators…
Age and obesity-associated changes in the expression and activation…