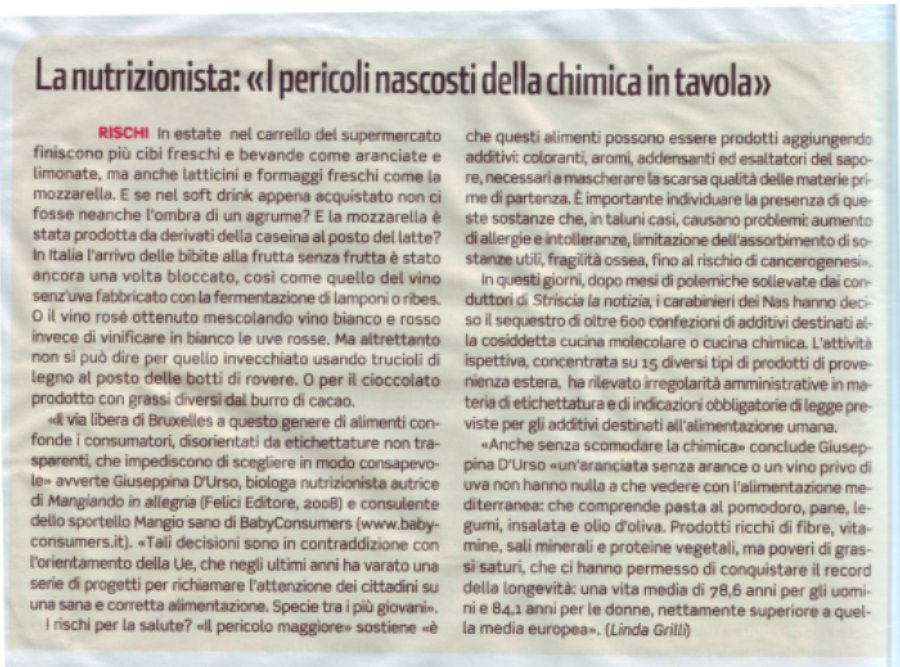Nella nostra società la disponibilità di cibo e la sedentarietà
Nella nostra società la disponibilità di cibo e la sedentarietà
hanno incrementato drammaticamente la prevalenza di obesità, soprattutto in età evolutiva. Dall’altra parte, i modelli di snellezza estrema che lusingano e angosciano gli adolescenti hanno finito col demonizzare tutti i grassi ed etichettarli come pericolosi, nonostante tali macronutrienti risultino invece indispensabili per il nostro organismo, purchè assunti secondo appropriati criteri qualitativi e quantitativi. La demonizzazione relativa ad alimenti con i quali l’uomo si nutre da millenni (burro, formaggio, uova) riduce inoltre il valore delle tradizioni e delle culture territoriali, che andrebbe invece difeso quale pilastro del modello alimentare mediterraneo.
Ci sorge spontaneo il dubbio di quali siano allora i grassi buoni e quelli cattivi. Sul banco degli imputati, accanto ai grassi trans, vi è una categoria di grassi spacciata spesso per “sana” ed innocua: gli oli tropicali di cocco, palma e palmisti. Questi oli di origine vegetale rappresentano un vero e proprio scherzo della natura. Infatti, a differenza degli altri oli vegetali (extravergine di oliva e di semi), ricchi di grassi monoinsaturi e polinsaturi, quelli tropicali contengono elevate quantità di grassi saturi (come quelli di origine animale), che hanno effetto negativo sul colesterolo e sulla formazione di placche aterosclerotiche (acidi grassi laurico, miristico e palmitico). Se
confrontassimo la percentuale di grassi saturi presente nei vari oli tropicali rispetto a quella presente nel burro toglieremmo a quest’ultimo il primato negativo che oggi spesso gli viene attribuito. Infatti abbiamo il 91% di grassi saturi nell’olio di cocco, l’83% in quello di palma e l’80% in quello di palmisti; mentre il burro ne contiene solo il 65%, oltre ad offrire un buon contenuto di calcio e vitamine. Ma a cosa servono, allora, gli oli tropicali? Essi garantiscono resistenza, friabilità e palatabilità alle elevate temperature della frittura, anche dopo una settimana di utilizzo intensivo e, cosa fondamentale, sono molto economici. Queste le prerogative che oggi rendono gli oli tropicali “ottimi”, dal punto di vista commerciale, per la
produzione di prodotti da forno, patatine fritte confezionate e per la realizzazione di miscele di oli vegetali e grassi animali variamente trattati, che rendono i prodotti più friabili e gustosi. Essendo questi oli di innegabile origine vegetale, essi vengono indicati in etichetta come oli vegetali , “tranquillizzando” così il consumatore. Una corretta educazione alimentare renderebbe il consumatore consapevole del loro elevato contenuto in grassi saturi, evitando quindi di preferirli al latte intero, al burro, alle uova e ai nostri tradizionali formaggi. Da non sottovalutare inoltre il problema del danno ambientale provocato alle foreste tropicali dalla coltivazione intensiva di intere zone deforestate, che, una volta utilizzate, vengono abbandonate poiché rese poco fertili dalle stesse modalità di coltivazione e dall’uso massiccio di pesticidi. Nonostante questo scempio sia sotto gli occhi di tutti e malgrado la mole di evidenze scientifiche sull’uso di questi oli dannosissimi spacciati per innocui oli vegetali, i dati relativi all’esportazione di tali prodotti sono davvero inquietanti: per il solo olio di palma si è passati infatti da 126.000 tonnellate nel 1985 a 12.000.000 di tonnellate nel 2007. Insomma, una quantità da capogiro di grassi saturi destinati ad insaporire cornetti, gelati, crackers, fette biscottate, merendine che ogni giorno arrivano sulle nostre tavole e, quel ch’è peggio, negli zaini dei nostri figli!
Citato in http://www.prezzinvista.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1574

 Spunti di nutrizione … ed altro
Spunti di nutrizione … ed altro